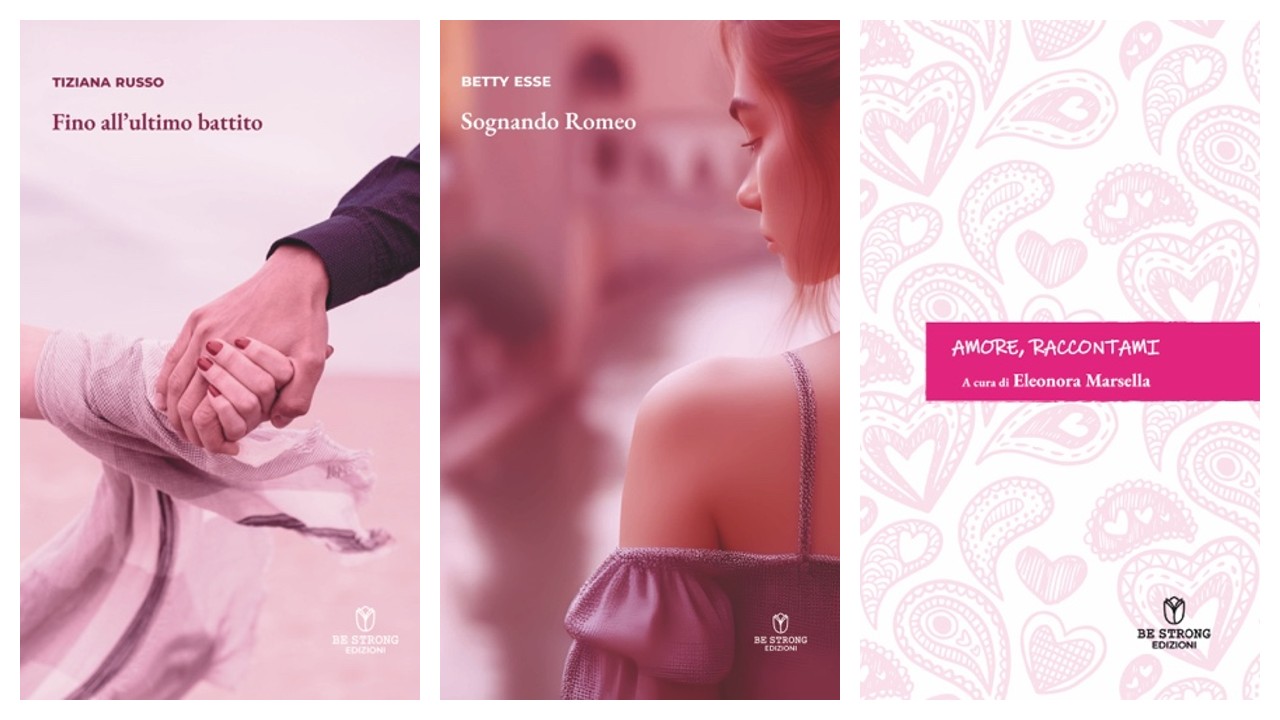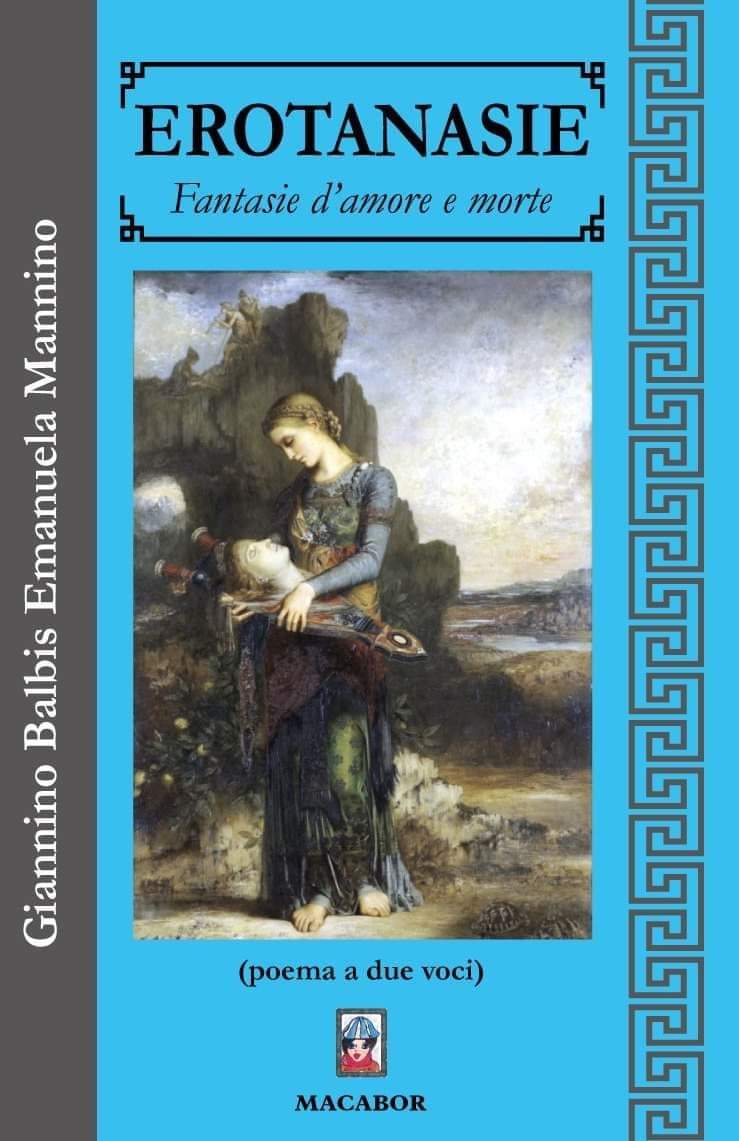di Ornella Mallo 29/04/2022
Ne “La prima radice” di Simone Weil leggiamo: “E ogni qual volta un frammento di verità inesprimibile si traduce nelle parole che, pur non potendo contenere la verità che le ha ispirate, hanno, grazie alla loro disposizione, una corrispondenza talmente perfetta da fornire un supporto a ogni spirito desideroso di ritrovarla, ogni volta che è così, una fulgida bellezza si diffonde sulle parole.” Le parole di Anna Maria Bonfiglio, dunque, come perle rifulgono di bellezza, dal momento che hanno il potere di esprimere la verità inesprimibile che giace sul fondo della sua anima di donna: ed è la femminilità, sia della poetessa che delle donne cui rivolge il suo sguardo, l’indiscussa protagonista della silloge “Di tanto vivere”. Scriveva la Merini: “Sei nata donna / ma tu sei così oscura / come tranello in cui tema il piede / di orizzontarsi. Sei la mia dimora, / la dimora traslata dalle vigne / che fa tacere anche il pavimento.” L’autrice si serve della poesia come di un bisturi, che usa per scavare dentro di sé, tirando fuori i tratti più intimi della sua personalità, talmente profondi da essere essenziali, e consentire così, ad ogni donna, di ritrovarli in sé stessa. Quindi la sua scrittura non è il semplice sgomitolare la matassa della propria interiorità, ritrovandone il bandolo, ma fa da specchio e da ritratto di altre figure di donna: dalla madre alle protagoniste della sezione “Miserere”, tutte accomunate da un altro elemento che intride la silloge, che è il dolore della condizione femminile. Dolore che può scaturire da ragioni diverse, ma che comunque dalla donna viene percepito in tutta la sua pervasività, prepotenza e immanenza, essendo depositaria del “grembo profondo” che genera vita. Nella silloge leggiamo: “ il dolore è peso / ombra che inquieta il sonno / morsa che ci fa odiare il pane / ed è più comodo / cacciarlo dalle orecchie / e dire che non ci appartiene. “ Eugenio Borgna, ne “Il tempo e la vita”, rileva che “la cultura occidentale considera oggi inaccettabile la presenza del dolore: del dolore del corpo e del dolore dell’anima. Ciascuno è disperatamente solo, dinnanzi al dolore.” L’autrice, invece, non ha paura di renderlo protagonista dei suoi versi, sia che si tratti del suo dolore personale, sia che si tratti di quello delle donne che offrono la propria vita in cambio della libertà; lo porta a galla e ne fa motivo di crescita, nonostante la società odierna lo inabissi deliberatamente sotto i liquami dell’edonismo più sfrenato, che vede come un ostacolo alla sua affermazione il prendersi cura della sofferenza dell’altro, ponendovi rimedio. Scrive la poetessa: “Cresceremo in dolore / enfiati da risorse avvelenate / stringendo i pugni / per non lasciar filtrare nostalgie.” E in “Canto minimo”: “Ora che la vita stride nelle ossa / ammalorate / la viola incide l’arco minimale / del canto che vorrebbe lievitare. / E l’accompagna un suono / come d’incanto / un incendio che esplode e si fa verso.” Non fa mistero della funzione che per lei ha la poesia, che deve ostinatamente annunciare la possibilità della nascita di una “luce dagli occhi / che hanno pianto” ; la necessità di un accoglimento di “mani coppe / a cui estinguere la sete”. In “Wait for sleep” scrive: “Non so se è insipienza / questo mio arrocco a difesa / della parola semplice e sguarnita / perla di liquido sentire / annuncio di aurora che ritorna / per carezzare l’anima nel deserto / di stupri e d’assassini”. Dunque, nei suoi versi “si leva il grido rattenuto / a resuscitare spasimi / guizzando ombre di pace / sulle agitate vele.” Ma non solo. Indubbiamente la Bonfiglio fa parte di quella categoria di donne che, come rileva Maria Grazia Calandrone, “non hanno solo scritto, ma hanno fatto, con le loro vite, poesia attiva”.Quest’ultima afferma che “in molti casi la poesia mette in scena l’esistenza di chi la scrive: quando il legame è tanto inestricabile, possiamo assistere al miracolo alchemico della vita (pace e ingiustizia, amore e tormento) che diventa bellezza. Una bellezza spesso aspra, combattuta. Ma certamente offerta. Una bellezza che non è trasfigurazione, ma che estrae musica anche dal corpo dolente. La musica che c’è, lo splendore che c’è.” Questo è uno di quei casi. La poetessa parla di sé stessa senza falsi pudori, si mette a nudo spogliando al contempo tutte le donne, di cui rivela l’essenza, fatta di fragilità e forza al contempo. Non a caso si identifica in una figura che incarna universalmente la femminilità, cioè in Lilith: nella poesia che nel titolo porta il suo nome, scrive: “S’apre il mare allo sguardo d’oriente / e fugge via la nottivaga Lilith / che ha frugato a tutte le porte / per trovare l’amore perduto. / Luna- donna / Luna- notte / Luna- vita / Luna – morte.” E, nella splendida “La donna di picche”, si rivela in tutta la sua nudità-verità. Scrive infatti: « L’occhiuta cartomante / inventava il destino / leggendo le figure capovolte / e i semi che uscivano per primi. / “La signorina crede nell’amore / (tinnivano al suo collo le catene) / il re di cuore parla molto chiaro / ma questa donna nera / ha purtroppo valenze negative.” / Ridemmo. / Ma la donna di picche / non era un’invenzione delle carte. » Dalle sue poesie emerge come quel desiderio, così femminile, di amare e di essere amata, trovando nell’uomo una corrispondenza adeguata, resti, nella sua vita, come nella vita di molte donne, poco più che un ideale irrealizzato e irrealizzabile. Scrive: “La casa ti aspettava / Rammendava gli strappi / con ragnatele di fili colorati / e immaginava per noi / quell’autunno che non venne mai: / la coperta sopra le ginocchia / ai piedi il nostro cane / a leccarci le dita /”. Oppure: “Non ti chiedo neppure cosa sono / nella tua vita di ferite e rughe. / Ti leggo sulle mani / i segni dei ritorni ripetuti / e so che sei per me pianto e carezza / stazione provvisoria ove si torna / mosca impazzita / nel dedalo dei sogni capovolti.” E, in “Una canzone”: “Ho sulle labbra / ancora una canzone / e una colomba calda / fra le mie mani / ho una canzone / di spade e di coltelli / per l’amore che / non verrà ad ornare / di muschio e di corallo / l’orlo del pozzo.” Guardando dentro sé stessa, la Bonfiglio trova ciò che la accomuna alle altre donne, verso cui rivolge lo sguardo solidale di chi ne condivide i bisogni e si sa fare interprete della loro condizione. Lo sguardo si posa allora sulla donna più importante della sua vita, con cui si è confrontata sin da subito, essendo colei che l’ha messa al mondo: sua madre. Splendida la “Ninnananna per la madre”: “E poi il dolore s’addolce / e silente s’accartoccia la pena. / Nel cavo del braccio / ti cullo amorosa e paziente / sei soltanto un ricordo / ed io sola / nel mondo che tu / mi hai lasciato nemico. / Oh madre d’antico lignaggio / ora piango / la pena che al tempo / non piansi abbastanza / […] Mia unica e sola bambina / – io madre tu figlia alla fine dei giorni – / niente fughe e ritorni / resto l’unica cosa / nella casa che dorme.” Nella sezione “Miserere” lo sguardo si allarga alle donne che hanno lottato e lottano per la libertà di autodeterminarsi. L’esergo è chiaro: “Dov’è la libertà / che urlava per le strade / il riscatto dei vinti?” Si va dai ritratti delle immigrate, di cui mette in risalto il dolore che provano nel “lasciare ciò che appartiene / ed è distrutto. / […] Si cammina col petto contratto e il pensiero che vola lontano / dall’inferno che brucia la pelle. / […] migrazione esilio / esodo transumanza diaspora – / aquiloni / che vanno controvento / verso un sole che ha calore diverso. /; all’omaggio a Reyhaneh Jabbari, impiccata nell’ottobre del 2014, e a Neda Agha Soltan, uccisa a Teheran durante una manifestazione politica. Per tutte le donne che lottano per il riconoscimento dei loro diritti, e per vivere una vita dignitosa, la poetessa leva il suo canto: “Madre, non piangere per me, per noi / che abbiamo camminato a testa alta / senza nient’altro domandare che giustizia. / Piangi, madre, per tutte le figlie / che piegano la testa rassegnate, / per la perseveranza delle madri / supine a tramandare / l’orrore che si portano nel sangue.” Leggendo questi versi, non ho potuto fare a meno di pensare a quanto scrive la Dickinson per spiegare quando si è davanti alla vera poesia. Citandola concludo la mia disamina, perché ogni altra parola sarebbe superflua. Scrive: “Se leggo un libro che mi gela tutta, così che nessun fuoco possa scaldarmi, so che è poesia. Se mi sento fisicamente come se mi scoperchiassero la testa, so che quella è poesia. E’ l’unico modo che ho per conoscerla. Ce ne sono altri?”